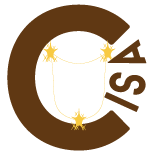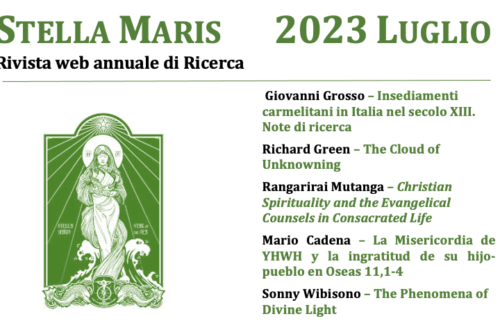IL RITO DELLA PENITENZA
Le Premesse al Rito (di p. Matteo Antollini)
Introduzione
Non tutti sanno dell’esistenza di un Rituale per il Sacramento della Riconciliazione. Il Rito della Penitenza esiste già dal 1974 e, per precisione, è entrato in vigore sul territorio di lingua italiana dalla seconda Domenica di Pasqua dello stesso anno. All’alba del Terzo Millennio, purtroppo, il Sacramento della Penitenza è forse quello meno richiesto, più temuto, più scartato e mal compreso. Questo piccolo lavoro vuole ricordare e riscoprire l’entusiasmo conciliare con il quale tale Sacramento è stato rivisto e ravvivato. Attraverso la lettura dei Prænotanda del Rito in questione, ho voluto riassumere i punti salienti per stimolare una consapevolezza del Rito e sottolineare l’importanza del ministero della “Confessione dei peccati” affidato ai sacerdoti.
Rito della Penitenza
L’introduzione al Rito della Penitenza[1] è articolata in sei punti: il Mistero della Riconciliazione nella Storia della Salvezza, la Riconciliazione dei penitenti nella Vita della Chiesa, uffici e ministeri nella Riconciliazione dei penitenti, Celebrazione del Sacramento della Penitenza, le Celebrazioni penitenziali e gli adattamenti del Rito alle varie regioni e alle diverse circostanze.
La prima sezione, a carattere storico, viene sviluppata attingendo alle molte citazioni neotestamentarie affinché l’amministrazione del Sacramento trovi, nella Parola di Dio, compimento dalle ammonizioni di Gesù Cristo rivolte alla Sua Chiesa permettendo così l’esperienza del Perdono del Padre attraverso il Suo disegno misericordioso e salvifico.
La seconda, di impronta teologica, associa il piano salvifico di Dio al Ministero della Chiesa la quale è santa ma sempre bisognosa di purificazione. Attraverso la Penitenza, i penitenti si riconciliano con la Chiesa, si ristabiliscono in amicizia con Dio e si impegnano costantemente alla conversione. I testi ai quali si riferisce la sezione sono alcuni documenti del Concilio Ecumenico Vaticano II, del Concilio Tridentino e le Costituzioni Apostoliche di s. Paolo VI: Indulgentiarum doctrina e Pænitemini; quest’ultima ci ricorda che «scopo quindi della penitenza è essenzialmente quello di riaccendere in noi l’amore di Dio e di riportarci pienamente a lui»[2]. La sezione teologica esplica quindi il Sacramento in sé e le sue parti: contrizione, confessione, soddisfazione e assoluzione. Ci viene ricordato inoltre che tale pratica è permessa grazie all’azione dei sacerdoti che, in persona Christi, accordano la remissione dei peccati. Senza la contrizione, la remissione del peccato non sarebbe possibile; il fedele che si rivolge al confessore, attraverso la memoria e l’esame di coscienza, è tenuto a confessare i peccati gravi e i peccati veniali. Nel mondo odierno, purtroppo, tale pratica è quasi dimenticata; alcuni la vivono come una abitudine sterile mentre bisognerebbe aiutare i fedeli a riscoprire la bellezza del Perdono, rinnovando l’impegno e la cura pastorale, spiegando il Rito in ogni sua parte e togliere al Sacramento quella pesantezza arrecata dai sacerdoti stessi nello svolgere il ministero affidato con tiepidezza o arcigno giudizio.
La terza sezione, di impostazione giuridica, sottolinea il compito che la Chiesa è chiamata a svolgere; essa è tenuta a esercitare la riconciliazione, annunciare la Parola di Dio che invita alla conversione, pregare per i peccatori, accompagnare i fedeli nell’esercizio del Sacramento, essere strumento di conversione e rimettere i peccati. Il Vescovo locale è il diretto responsabile di tale pratica ed agisce in comunione con i presbiteri aventi facoltà di confessare.
Si fa presente l’importanza della dovuta formazione a tale ministero accompagnata da saggezza, scienza, discernimento, prudenza, pronta disponibilità e attitudine paterna in quanto «il discernimento degli spiriti è l’intima cognizione dell’opera di Dio nel cuore degli uomini: dono dello Spirito Santo e frutto della carità»[3]. La segretezza delle coscienze dei fedeli è consegnata al confessore con l’impegno del sigillo sacramentale, pena la scomunica. Non di minor importanza, si ricorda che la liturgia della Chiesa nel Rito della penitenza è celebrata dal sacerdote insieme al fedele.
Sul piano liturgico, nella quarta sezione delle Premesse al Rito, il sacerdote viene avviato al ministero seguendo le istruzioni fornite. C’è un luogo adatto alla celebrazione, soprattutto ora a seguito di scandali e pettegolezzi è bene pensare a sedi idonee, rispettose, che garantiscano al fedele, ma anche al confessore, rispetto, riservatezza, segretezza e trasparenza d’ufficio. Si chiede esplicitamente di «inculcare nei fedeli l’abitudine di accostarsi al sacramento della Penitenza fuori della celebrazione della Messa, e preferibilmente in ore stabilite»[4] perché oltre allo spazio, la confessione ha anche un suo tempo. Anche su questo punto, oggi come oggi, si dovrebbe dimostrare cura pastorale nello spiegare il perché di tale saggia decisione originaria e non concedere confessioni estemporanee qualche secondo prima della Eucarestia o in orari scomodi per i fedeli. Il rituale stesso propone l’intensificazione di tale ministero nel tempo forte quaresimale, offrendo anche celebrazioni penitenziali. Riassumendo: luogo adatto, tempo opportuno e vesti liturgiche previste dagli Ordinari dei luoghi[5].
Il Rito prescrive le norme per la riconciliazione dei singoli penitenti: la preghiera previa di entrambe le parti, sacerdote e fedele; l’invocazione dello Spirito Santo da parte del presbitero per chiedere il discernimento e l’esame di coscienza da parte del penitente. Dopo la preparazione, il Rito è articolato in: accoglienza, segno di Croce, lettura della Parola di Dio, la confessione dei peccati, l’accettazione della cosiddetta soddisfazione, l’assoluzione del sacerdote, il rendimento di grazie e il congedo. L’accoglienza andrebbe fatta con «affabile dolcezza»[6] da parte del sacerdote: è basilare questa disposizione perché essa influenza la serenità di apertura, da parte del penitente, e garantisce il momento favorevole al Sacramento che sta per essere celebrato. Quante volte si verifica l’esatto contrario nei nostri confessionali: sacerdoti superficiali, frettolosi, impreparati e insensibili che dimostrano incapacità in un dovere così elementare e necessario.
Fatto il segno di croce, si legge un testo della Sacra Scrittura; il formulario ne prevede più di dieci ma è interessante ricordare che il penitente e il sacerdote possono leggere un testo della Scrittura a scelta[7]. Tale lettura può anche essere svolta in preparazione al sacramento: si potrebbe pensare di lasciare, vicino ai confessionali, pieghevoli contenenti brevi testi tratti dalla Bibbia.
Il penitente confessa poi i suoi peccati, cominciando, dove c’è l’uso, dalla formula della confessione generale (per es. il Confesso a Dio). Il sacerdote lo aiuti, se necessario, a fare con integrità la sua confessione, lo esorti a pentirsi sinceramente delle offese fatte a Dio, gli rivolga buoni consigli per indurlo a iniziare una vita nuova, e lo istruisca, qualora ce ne fosse bisogno, sui doveri della vita cristiana.[8]
In vista dell’assoluzione, il penitente «manifesta la sua contrizione e il proposito di una vita nuova, recitando una preghiera»[9] a tal proposito il Rito propone dieci formule di preghiere. L’assoluzione è siglata con un segno di croce tracciato dal Sacerdote sul fedele perché:
indica che la riconciliazione del penitente viene dalla misericordia del Padre; fa vedere il nesso fra la riconciliazione del penitente e il mistero pasquale di Cristo; sottolinea l’azione dello Spirito Santo nella remissione dei peccati; mette in luce infine l’aspetto ecclesiale del sacramento per il fatto che la riconciliazione con Dio viene richiesta e concessa mediante il ministero della Chiesa.[10]
Infine, il sacerdote e il penitente riconciliato, emettono un rendimento di grazie con parole opportune ovvero consigliate dal Rito stesso. Il Rito può essere abbreviato «se una necessità pastorale lo consiglia»[11] purtroppo è la prassi odierna ove la Parola di Dio viene sempre omessa. Ci viene ricordato che nel caso di pericolo di morte imminente è sufficiente che il sacerdote pronunci la formula di assoluzione.
Sempre sul piano liturgico è prevista anche la possibilità di celebrare il Rito per la riconciliazione di più penitenti con la confessione e l’assoluzione individuale, chiamate anche “Celebrazioni penitenziali” ove la «Celebrazione comune manifesta più chiaramente la natura ecclesiale della penitenza»[12]. Lo schema proposto, rispetto al Rito svolto con il singolo penitente, prevede l’ampliamento della Celebrazione con canti adatti, momenti di silenzio, possibilità di più letture come per esempio, due letture, un salmo e l’acclamazione di un passo del Vangelo, l’omelia, il Confiteo, la recita del Padre nostro, la distribuzione dei sacerdoti nei luoghi previsti per le confessioni individuali, il ricongiungimento dei sacerdoti nel presbiterio al termine delle confessioni, il rendimento di grazie comunitario fatto con un salmo, un inno o una preghiera litanica, l’orazione, la benedizione e il congedo finale.
Ci sarebbe quindi un ulteriore Rito previsto per la riconciliazione di più penitenti con la confessione e l’assoluzione generale; tale possibilità è concessa in casi particolari, soprattutto nel caso concreto di morte imminente (si pensi al sacerdote insieme a un gruppo di persone che si trovano incidentati in mezzi di locomozione come navi, aerei, treni, autobus o casi simili) l’azione tempestiva del sacerdote è supportata dalla possibilità di abbreviare il Rito con la sola pronuncia della formula di assoluzione. Tuttavia, è possibile amministrare tale riconciliazione di più penitenti senza confessione individuale stabiliti dal diritto e se giudicati leciti dal «Vescovo diocesano, d’intesa con gli altri membri della Conferenza Episcopale»[13]. Tale pratica è regolamentata da una procedura rigida perché i fedeli «in modo assoluto siano ben disposti, ognuno si penta dei peccati commessi, intenda riparare gli scandali e i danni eventualmente provocati e si impegni inoltre alla singola confessione» entro l’anno visto che il fedele è chiamato a confessarsi «almeno una volta all’anno»[14]. Così anche il confessore è tenuto, previa autorizzazione dell’Ordinario del luogo, a considerare la casistica prevista e la situazione eccezionale presentatasi; il Rito così pensato è rivolto alle terre di missione ove non c’è tempo né confessori sufficienti allo svolgimento della pratica. Da sottolineare:
Coloro ai quali vengono rimessi i peccati gravi mediane l’assoluzione collettiva, prima di ricevere nuovamente una tale assoluzione, devono accostarsi alla confessione auricolare, a meno che non ne siano impediti da una giusta causa. Sono però strettamente obbligati, tolto il caso di impossibilità morale, a presentarsi entro un anno al confessore.[15]
L’ultima sezione, quella pastorale, ricorda l’importanza e l’utilità che si compie con le Celebrazioni penitenziali a beneficio del popolo di Dio, nei vari tempi dell’anno liturgico, nell’educare i giovani e i bambini, nell’accompagnare e ravvivare una comunità parrocchiale. Gli adattamenti del rito alle varie regioni e circostanze sono dettate dalle Conferenze Episcopali con l’approvazione della Santa Sede.
Conclusione
In ultima analisi, il Sacramento della Riconciliazione è l’incontro con il Padre, il Dio di Misericordia[16]. Questo lavoro mi ha aiutato a sintetizzare il pensiero con il quale è stato concepito il Rito, oltre cinquant’anni fa, per vedere come oggi, nel Giubileo del 2025, ogni sacerdote e fedele siamo invitati a riscoprirne il significato e restituire la bellezza dell’incontro tra noi e il Figlio di Dio che ci dice: «Figlio, ti sono perdonati i peccati»[17].
In definitiva: riportare la Parola di Dio nella prassi del Sacramento.
[1] Il Rito della Penitenza, Edizioni Conferenza Episcopale Italiana, Roma 1974.
[2] Ibidem, 16-17.
[3] Ibidem, 22.
[4] Ibidem, 24.
[5] Cfr. Ibidem,25.
[6] Ibidem, 25.
[7] Cfr. Ibidem, 47.
[8] Ibidem, 26.
[9] Ibidem, 26.
[10] Ibidem, 26.
[11] Ibidem, 27.
[12] Ibidem, 27.
[13] Ibidem, 31.
[14] Cfr. CCC, n. 2042.
[15] Il Rito della Penitenza, 32.
[16] Cfr. PAPA FRANCESCO-TORNIELLI A., Il nome di Dio è Misericordia, PIEMME, Milano 2016.
[17] Mc 2, 5.